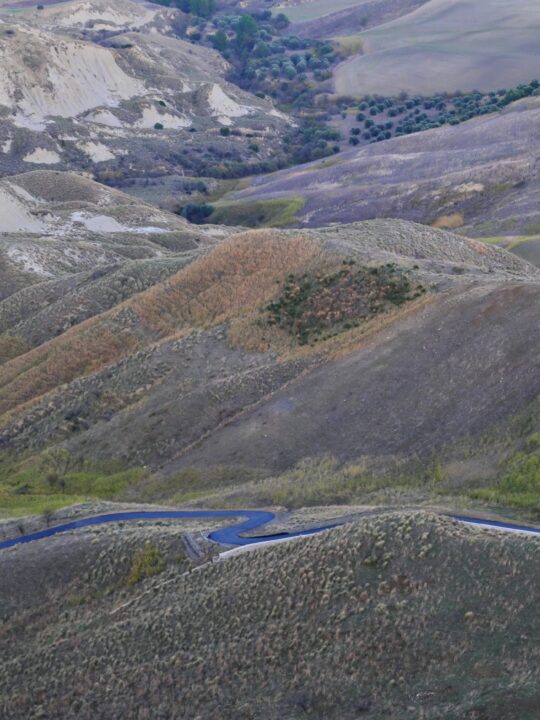Senza te
Chissà se ti ricordi come mi chiamo ora che abiti al di là della Manica in una di quelle casette a schiera tutte uguali coi gerani al balcone e le piastrelle di ceramica marrone. Ho visto le foto sì, pure quelle di un anno fa dove ridevi col braccio dietro al collo di lei che ha preso il posto mio. Vi guardo e vi odio, vi odio di un silenzio che mi rimbomba dentro il fegato e si fa verde di bile e rancore. Si gonfia e sale di notte senza farsi nemmeno sentire, zitto zitto, quatto quatto, sale e brucia fino alla gola. Si mescola alle gocce tranquillanti omeopatiche che mi ha prescritto il dottore per farmi dormire e rimane lì come il brutto sapore che hanno le mie mattine: c’hai presente l’amarezza? Il dolore, la tristezza? La delusione il rimpianto l’afflizione? La mestizia? Ecco sì, dev’essere la mestizia che di notte mi pungola il braccio col suo indice affilato e mi si infila dentro la bocca socchiusa appena apro gli occhi. Per dispetto forse o perché vuole che ne muoia. Di lei o di te perché di noi ormai non si ricorda più nessuno.
D’altronde a volte mi chiedo se siamo davvero esistiti, se questo anello che porto ancora al dito sia un avanzo di speranza da riporre da qualche parte o un monito severo sovraccarico di terrore. Come dire: guardami e ricordati di com’è andata. Di cosa sanno l’argento e gli zirconi quando lo spazio tra le dita rimane vuoto come il bidone del vetro che ho messo fuori ieri sera. La tazza che mi portasti da Londra, due bottiglie di vino bianco e ventisei canadesi con l’etichetta scorticata conservate come reliquie sul pianerottolo delle scale. Sette mesi di devo farlo non ce la faccio oggi domani oggi domani non ce la faccio devo farlo devo farlo e poi alla fine ce l’ho fatta, a metterci fuori dal portoncino di casa mia e aspettare che i netturbini passassero stamattina presto a scaricarci in mezzo ad altre centinaia, migliaia di bottiglie vuote. Ci hanno sollevato con due mani, portato al di sopra delle spalle e rigirato senza alcuna attenzione dentro un camioncino arancione anonimo e puzzolente. Abbiamo fatto un rumore scintillante, amore, come di una cascata di conchiglie ambrate che piovono una sull’altra e si scheggiano e si frantumano le ossa. Che belli che eravamo visti da sopra il balcone, anonimi e uguali a tanti altri: differenziati per diventare qualcos’altro. Forse.
Nel primo cassetto del comò mi son rimasti nove paia di calzini tuoi, un paio di slip scoloriti dal silenzio e due preservativi ancora chiusi. Stamattina coi tuoi slip ci ho spolverato i mobili del salone, mi sembra che catturino bene lo sporco e tutti quei piccoli insettini minuscoli invisibili che chiamano acari ma a cui il tuo nome starebbe proprio bene. Pelle, unghie e fibre di vestiti che alimentano parassiti molli e antichissimi. Non conosco nessuno che li abbia visti ad occhio nudo, non sono neanche sicura che esistano per davvero però il grigio della polvere fa pendant col verde sbiadito, non credi? Con te che sei uova che esplodono e schizzano larve sui muri del mio amore e crescono e si nutrono dei segreti che ho nascosto quel giorno tra i fili del tappeto e le ciabatte vecchie. Ho tra i capelli i fiori del giubbino che mi hai regalato quando era in saldo da Promod anche se la taglia era troppo piccola per me e te l’avevo detto ma mi piace troppo e te lo regalo lo stesso perché ti sta bene. Duemila cazzotti e un paio di shorts invernali, il reggiseno, gli slip di pizzo nero, il baby doll e il fermacapelli coi fiorellini bianchi. Te li ricordi i fiorellini bianchi?
Di tanto in tanto lavo sotto acqua fredda la promessa che mi hai lasciato sulla mensola della cucina, proprio sopra al caminetto. Ho dondolato nel mare di notte e ci ho trovato questa, hai detto. Te la presto ma la rivoglio indietro con te. A casa mia. Sabbia, fango e calcio come una sorta di scatola durissima in cui io ho vissuto come un animale senza scheletro, come il mantello che ripiego ora con cura e da cui mi lascio avvolgere. Strati e strati di proteine e madreperla, calcare e piastre flessibili che col tempo si sono calcificate e mi hanno incurvata mentre mi lasciavo avvolgere a spirale su me stessa e mi perdevo nell’eco di questa conchiglia. Ancestrale, conica, sempre più alta per me, che ho dovuto imparare a flettermi per compensare questo inconveniente, a torcermi con tutto il corpo per ritrovare il baricentro di un equilibrio più o meno efficiente. Compatta e chiusa da una cerniera dorsale che si è ispessita per allontanarmi da te che sei il legamento lesionato dei miei muscoli. Sì, ho sviluppato una nuova fila di denti e fossette di varia forma in cui faccio galleggiare le tue impronte come in una camera ricolma di gas e tubi fragilissimi. Ho deciso di portarla ad un mercatino, la tua promessa, e scambiarla con uno di quegli oggetti inutili che hanno tutti. Non lo so, magari uno svota tasche.
Di te mi rimane anche una confezione di deodorante, un gel per capelli e una reflex comprata a società per festeggiare san valentino. L’ho ritrovata per caso l’altro giorno nel sottoscala e mi sono chiesta perché. Diavolo. Non l’ho mai usata in tutto questo tempo. Tempo esposizione messa a fuoco luce diaframma. Tempo. Mi ci è voluto tempo, sì, per riconoscere te e me nel video e nelle 126 foto che ho cancellato meccanicamente senza sentire niente. Nemmeno un clic al cuore. Come se questo fosse avvolto da una pellicola di stagno e bitume che lo hanno reso oscuro, umano e antico. Tu nell’obbiettivo del mio foglio bianco, dall’interno di questo piccolo apparecchio ti faccio emergere e poi sprofondare insieme alle mie visioni perché voglio che diventi semplice fenomeno riciclato. Specchio di un’immagine capovolta di me che non mi appartiene più.
Il tuo spazzolino bianco e verde con le setole consumate: ho continuato ad usarlo per mesi, per sentire il tuo sapore tra i denti e le gengive e avvelenarmi giorno dopo giorno di te che sapevi di menta, fluoro e batteri. Infettarmi di proposito, farmi penetrare per sentirti scorrere e corroderti dentro di me come se fossi una malattia che mi intacca i tessuti duri e che si spinge dentro, fin dentro la polpa della matrice minerale di cui son fatte le mie lesioni più crude. E son diventata sensibile al freddo, sai, adesso che stai in profondità, insieme alle carie putrefatte e agli zuccheri del tempo. Commensali indispensabili d’equilibrio, forieri di potenziali patogeni che mi opacizzano l’impeto e mi rendono acida. Solubile come i residui porosi e superficiali di ciò che è già stato e che oggi distruggo. Piano. Completamente. Sputandoci sopra saliva e cellule bianche di sangue come aggettivi salati, meccanismi di difesa e cattive abitudini accumulate nei flussi della disarmonia.
Quando mi manchi ti lascio sfumare nella friggitrice che abbiamo vinto coi punti della benzina, aggiungo qualche parola a queste righe oppure passo la crema anticellulite sulle mie cosce piene zeppe di te. Che mi sei rimasto aggrappato ai fianchi come un’infiammazione cancrenosa, come un non-argomento di importanza minore che ti consacra, semplicemente: malattia inventata. Un insieme di noduli più o meno dolenti che mi rendono sospettosa e che continuano ad accumularsi giusto al di sotto del mio tessuto adiposo. Che bella parola: adiposo. E che bella: io.
Mi vedessi ora, amore, ho una pancia rotonda rotonda, due seni grossi e turgidi che in questi mesi si son gonfiati e che si riempiranno di latte e d’amore perchè no, quel giorno non l’ho presa la pillola che mi avevi chiesto di comprare in farmacia perché forse non eri stato attento, hai detto. Mi hai dato un bacio sulla fronte, ti sei vestito per andare al lavoro e poi boh, non ti ho visto più. Un figlio da crescere lo sognavo da anni, e lo sapevi, eppure quel giorno mi hai chiesto di rinunciarci perché in fondo tu un figlio ce l’avevi già. Ma io mica lo sapevo. Mica me l’avevi detto. Avrei dovuto dimenticare il mio sogno per rispettare te ma io invece ho voluto essere egoista. Per una volta. Almeno per una volta nella vita fare quello di cui non mi pentirò mai. Diventare madre. Sono rimasta incinta il giorno che mi hai lasciata e quindi sì, tra due mesi nascerà una bambina. La chiamerò Anna e il suo nome si leggerà da
destra a sinistra e poi da sinistra a destra e non cambierà niente e questo avrà senso per me. Iniziare dalla fine. E avere senso comunque. Anna è il segno che non doveva finire. E che io non sono finita. Senza te.
Di me ti rimangono:
un contenitore di plastica con dentro semi misti
due bidoni rossi
un testo che porta il tuo cognome
un servizio di piatti in ceramica
una brocca
un portacandele a forma di lampadina
due libri comprati
uno regalato
uno zerbino marrone coi fiori rossi
un maglione bordeaux
due spazzolini
una scatola di assorbenti interni
un lenzuolo arancione
la coperta verde che mi regalò mia nonna (cazzo!)
due camicie
un orologio
87 mattoni
quattro tendine rosse con la fascia a coralli
due fogliettini con sopra delle x.
delle parole d’amore scritte sui tovaglioli scottex
un armadio ordinato
una foto tra gli scontrini Ikea
queste righe
una pallina di gomma.
Cristina Carlà

SENZA TE diCristina Carlà è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Based on a work at https://www.colorivivacimagazine.com/2018/06/senza-te/ .
Permessi ulteriori rispetto alle finalità della presente licenza possono essere disponibili presso carlatraduzioni@gmail.com.