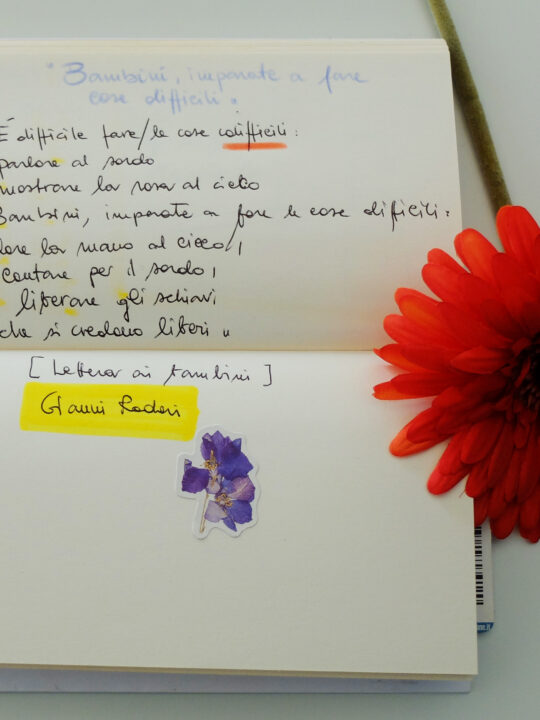Appino – “Il Testamento” (Una quasi-recensione con qualche colpevole mese di ritardo)
Trova lavoro in negozi, bar o ristoranti.
Più di 10.000 offerte aggiornate su Bakeca.it
Avete presente il colpo di fulmine?
Quella sensazione che s’impossessa di te da un momento all’altro e ti lascia sfatto, con la certezza che qualcosa si sia smosso e, da quel momento in poi, non ti lascerà più scampo?
A volte ci sono dei dischi che ti colpiscono con la stessa intensità, e dalle prime note capisci che ti hanno letto dentro e ti porteranno per mano per lunghissimo tempo.
Questa premessa è doverosa per farvi capire che quella che state leggendo non è una recensione bensì il racconto di ciò che un album – sto parlando de “Il Testamento” di Appino – mi comunica ad ogni ascolto. D’altronde io sono un parolaio, non un giornalista, quindi preferisco il raccontare al commentare.
Tanto per darvi delle coordinate, Andrea Appino è meglio noto come il cantante dei Zen circus, una interessante band del panorama indie italiano, che mi piace ma non mi ha mai scosso come è riuscito a fare questo progetto solista. E per proseguire con dei punti saldi interessanti, nel suo “Il testamento” suonano anche persone del calibro di Giulio Favero e Franz Valente del Teatro degli orrori e Rodrigo D’Erasmo. Tutti nomi che, a chi segue il buon rock indipendente italiano, giungono tutt’altro che nuovi.
Ma le coordinate, a me, non sono state necessarie quando, dalle prime note della title track ho capito che quest’album parlava la mia stessa lingua. Si parte con un violino malinconico che sfocia in un’esplosione di chitarre, poi le parole “Ho dieci strofe per lasciare un bel ricordo / ho dieci piani che mi aspettano giù in fondo” ti fanno immediatamente tuffare insieme al cantautore in un viaggio pericolosamente intrigante. Sì, insomma, la prima canzone parla di uno che ha scelto di saltar giù da un cornicione e lo fa con una melodia accattivante, un po’ mesta ma anche leggermente scanzonata. Qualcuno di voi, estimatori del genere, ricorderà sicuramente Precipito che apriva l’album di Giorgio Canali & Rossofuoco. Ecco, siamo lì.
Qual è la cosa più strana? Che a me, questa canzone, mette allegria.
Sì, ho detto allegria.
Mi fa venir voglia di passeggiare sogghignando per strade assolate in giornate invernali, forse persino di ridere e intanto canticchiare cose tipo “Io ho scelto esattamente tutto quel che sono / senza la scelta io la vita l’abbandono / ho scelto tutto, tutto tranne il mio dolore / lo ammazzo io e non c’è niente da capire”. Sarà che chi è abituato a giocare con la morte, quando vede qualcuno che ne canta con tanta disinvoltura si rende conto che può fargli meno paura, che può essere esorcizzata, persino sconfitta sorridendogli in faccia.
Ma poi, in mezzo a tanta apparente disperazione, c’è spazio anche per una goccia di dolcezza: “Ho scelto te per dei motivi misteriosi / siam stati accanto per giorni meravigliosi / e lo sai bene che lo faccio per natura / non rivederti più è l’unica paura” e ti ritrovi a chiederti se Appino stia parlando di una donna – da cui l’idea di separarsi gli provoca immenso dolore – oppure se stia flirtando con la Nera Signora. Magari con entrambe.
Il Testamento è album di rock con linee melodiche molto accattivanti, mai banale, a volte energico, a volte un po’ tendente a toni dark. Passaporto ha un giro di basso splendido, che sembra uscito dalle dita del miglior Maroccolo dei C.S.I., ma del resto i punti di riferimento musicali del cantautore pisano sembrano chiaramente appartenere a quell’area: dai Joy Division ai CCCP/CSI passando per tanti nomi del punk e della new wave.
Poi, però, arriva una splendida sorpresa che destabilizza l’ascoltatore che fino a quel momento aveva pensato di aver trovato tutte le giuste coordinate: s’intitola La festa della liberazione ed è una ballata folk struggente, che sembra uscita delle corde dei Modena city ramblers. 6 minuti e 24 secondi di poesia irriverente che parla di amplessi, verginità, seghe e di atei che pregano “di più di chi si inginocchia”.
Nel ritmo concitato a metà fra un rap e un recitato alla Pierpaolo Capovilla di Solo gli stronzi muoiono Appino si confessa parlando col buio: “io da bambino avevo una gran paura del buio / ma così tanta che una notte pensavo “ora muoio” / poi mi decisi, presi fiato e cominciai a parlarci / mi rispose e si mise pure a rassicurarmi / mi diceva che tutti avevan fifa di lui / e che la notte era un posto fatto apposta per noi / per noi bambini che il giorno non ci troviamo mai / non è la notte né la morte siamo soltanto noi”. Sì, devo confessare che leggere queste parole è stato come rivedere il me stesso bambino che cresce e diventa adulto nel giro di un minuto.
Si passa poi al freddo de I giorni della merla e dei rapporti sbagliati fra uomini e donne, uomini a cui “nessuno ha mai insegnato che una moglie anche si ama” per poi sfociare in una dedica piena di inconsapevole amore: “bambina mia adorata, gioiello di famiglia / sorella di una fata, bambina meraviglia / in questi giorni della merla dormi sempre più beata / sotto il tuo manto di neve
nella valle incantata”
In Schizofrenia, invece, compare davvero la voce di Capovilla e ci si perde fra un ritmo incalzante e un cantato rabbioso che tiene fede al titolo del brano senza cedere di un millimetro, fino ad invocare il Risperidone nei versi finali.
Il Testamento si chiude, poi, con un’altra splendida ballata sul falso mito degli anni ’80 che ti lascia con la voglia di ricominciare – subito – dall’inizio del disco.
Un album da ascoltare – senza dubbio – da gustare, da non confondere con i pur validi Zen circus, da amare e da leggere, perché se si lascia voler bene così tanto è anche per la lucida poetica dei testi.