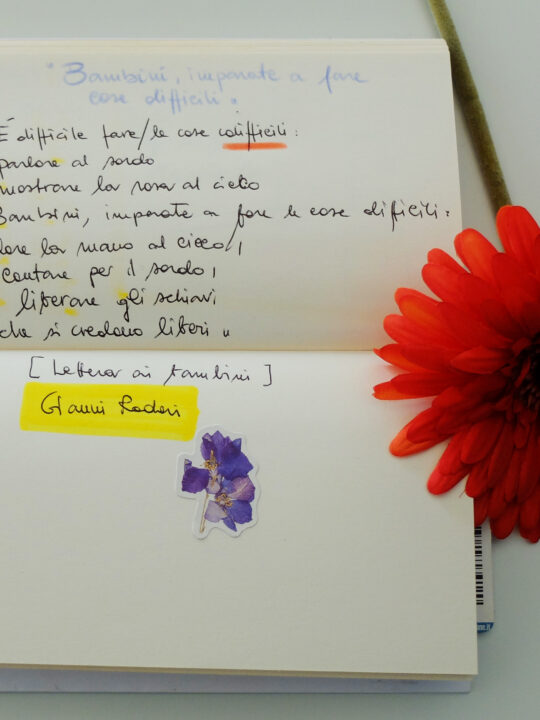Leonard Freed
Fotogiornalismo, testimonianza e poesia
“Alla fine la fotografia rappresenta chi sei. E’ la ricerca della verità in relazione a se stessi. E ricerca della verità diventa un’abitudine.”
Leonard Freed
Nato a New York nel 1929, da una famiglia di immigrati ebrei e operai, Leonard Freed voleva diventare un pittore ma fu ben presto conquistato dalla fotografia. Freed si è sempre interessato a chi vive e opera al margine della società, divenendo uno dei più famosi fotogiornalisti americani per le sue immagini sulle comunità ebraiche nel mondo, sulla condizione dei neri d’America, sul movimento dei diritti civili americano, sulle vittime di crimini violenti, sul lavoro della polizia, sui fronte di guerre grandi o dimenticate. È entrato a far parte dell’agenzia Magnum nel 1972. Autore di numerosi libri fotografici, collabora con le maggiori testate della stampa internazionale. Lo abbiamo incontrato, durante il suo recente passaggio a Roma, in occasione della mostra Genti&Luoghi, organizzata da Acta International: 25 immagini in bianco e nero tra le più suggestive realizzate da Freed intorno al mondo.
Che definizione darebbe di se stesso?
Sono un po’ di tutto, come nei sogni in cui a volte sei una cosa e poi un’altra. Sono di destra, sono di sinistra. Sono religioso, antireligioso. Amo le donne, le odio. Tutto mi attraversa come in un sogno. Sono come uno studente curioso, che vuole sempre imparare. Per poter fotografare devi prima avere un’opinione, devi prendere una decisione. Poi, quando stai fotografando, sei immerso nell’esperienza, diventi parte di ciò che stai fotografando. Devi immedesimarti nella psicologia di chi stai per fotografare, pensare ciò che lui pensa, essere sempre molto amichevole e neutrale.
Cosa deve esserci in una buona foto di reportage?
La foto non deve aver bisogno di una spiegazione, deve trasmettere un messaggio forte di per sé. Non dovrebbe essere accompagnata da una didascalia. Altrimenti non è una buona foto. Ci sono due lingue, quella visiva e quella letteraria. La lingua letteraria è la didascalia, la lingua visiva è la fotografia e quest’ultima dovrebbe dire tutto. Le fotografie dovrebbero parlare da sole la loro lingua.
Prima di tutto occorre che ci sia una buona composizione che possa funzionare come astrazione, che è come le fondamenta di una casa: se non ci sono delle buone fondamenta la casa crolla. Poi la fotografia deve raccontare una storia, la gente deve guardarla come se stesse leggendo una poesia. Una buona fotografia deve essere come un piccolo poema, l’osservatore deve percepirlo così e a questo contribuisce molto anche il taglio di luce. Per fare un buon servizio devi conoscere bene la psicologia del giornale e del photo-editor, ma serve sempre una buona apertura, qualche foto descrittiva e una bella foto di chiusura, una foto che deve dire “finito”.
È favorevole all’uso del computer?
Per me la fotografia è una religione e io sono molto osservante. Bisogna cercare la verità, dire la verità, mostrarla al pubblico. Anche per questo le mie foto non sono manipolate, non le rendo più chiare o più scure perché siano più incisive. Le foto devono essere naturali. Se usi il computer (a meno che non dichiari apertamente: “questa è una foto manipolata”), allora stai mentendo, stai ingannando la gente. È importante che la gente creda alla foto che sta guardando.
Lei è stato spesso in zone di guerra; cosa pensa dei reporter catturati o uccisi di recente in Afghanistan?
Ho avuto molte volte un fucile puntato contro, in Africa, in Libano in Cipro. E diversi miei colleghi sono stati uccisi. Ma non sono un soldato, non mi è stato ordinato di andarci e se perdo un braccio o la vita è soltanto mia responsabilità. Se un soldato viene colpito accanto a me penso sempre che sarebbe potuto accadere a me.
Una volta ero vicino a un carro armato che era saltato in aria e i soldati feriti ma ancora vivi erano stati tirati fuori e prima di fotografarli ho voluto che gli fossero coperti gli occhi perché ho pensato alle loro famiglie che avrebbero visto quelle foto e non volevo sfruttare le persone. Perché, in fondo, devi poter vivere con te stesso. Se non puoi vivere con te stesso è meglio che non fotografi. Puoi mentire agli altri, ma non a te stesso. Per me è molto importante mantenere la mia integrità.
Come ha visto cambiare negli anni il mestiere di fotogiornalista?
Primo: oggi ci sono meno soldi. Quando ho iniziato, i fotografi delle riviste erano molto importanti, c’erano incarichi sul posto più lunghi e perciò riuscivi a conoscerlo e a documentarlo meglio. Ora la televisione arriva prima. Fotografare è diventato molto complicato. Devi avere un incarico, parlare con il personale delle relazioni pubbliche, eccetera. Ma le storie migliori, non pure notizie, sono sempre fatte da foto.
E come è cambiato il suo corredo fotografico?
Ho iniziato con una Rolleiflex, bella ma lenta per raccontare storie. Poi il formato Leica con 90 e 28 mm, flash, eccetera. Il tutto molto pesante, specialmente se le ottiche sono luminose. Tutto il giorno con il peso appresso è stancante. Oggi la mia attrezzatura prevede poca roba, perché se perdi tempo a cambiare obiettivo il momento se ne va. È più importante cogliere l’attimo piuttosto che riflettere sull’attrezzatura migliore in quell’attimo. Uso soprattutto 35 e 50 mm.
Bianco e nero o colore?
Se un giornale mi chiede di fotografare a colori lo faccio, ma per me stesso. Ormai lavoro sempre di più per me stesso. Preferisco il bianco e nero. Io non ho niente a che fare con i colori. Se voglio vedere colori, guardo un quadro. Il bianco e nero trasmette meglio la personalità del soggetto senza che l’occhio dell’osservatore sia distratto dai colori. E poi anche il colore non è la realtà, proprio come il bianco e nero. Le tonalità esatte le dà chi produce le pellicole: Fuji più arancio, Kodak più marrone, Agfa ancora un altro colore. È chiaro che la foto-pittura va meglio a colori: un mazzo di fiori preferisco fotografarlo a colori, ma per le storie è meglio il bianco e nero.
Quindi ora sta lavorando più per se stesso? A cosa in particolare?
Si, ora sto fotografando più per me stesso. Ora, per esempio, sto fotografando Roma e sto preparando un progetto che alla fine si concretizzerà in un libro e una mostra su Roma. Ma non sono tanto interessato al libro o alla mostra; quello che più conta è essere a Roma, il processo del fotografare, l’esperienza fisica. Io, se non fotografo, mi sento grasso, malato. Come un corridore ha bisogno di allenarsi correndo, così io devo muovermi, camminare. Ma lo devo fare con uno scopo, che è quello di fare fotografie. Se vado in giro a fotografare sto bene fisicamente e mentalmente.
Viaggiare e fotografare sono per me un bisogno fisico. Fotografare non è certo un lavoro per diventare ricchi, ma se vivi semplicemente va bene. Certo se vai in night-club e ristoranti costosi i soldi finiscono in fretta. Conosco fotografi che possono permettersi ristoranti molto cari, ma hanno genitori molto ricchi o hanno sposato qualcuno molto ricco. Questo è un lavoro che si fa per amore, non per denaro. Non è un modo per diventare ricchi, ma è piacevole e anche avere una mostra come questa mi dà grande soddisfazione. Faccio sempre più spesso workshop in Europa, Italia compresa.
Ama viaggiare? Quali viaggi ricorda con più piacere?
Se mi siedo alla scrivania a un certo punto divento nervoso e devo andare, devo viaggiare. Ma allo stesso tempo, quando viaggio, ho bisogno anche di fermarmi. Ora viaggio da tre mesi e ho bisogno di tornare, perché quando viaggio lo faccio per 24 ore al giorno. Sento che è tempo di tornare nei boschi, mi mancano gli alberi, i miei alberi! Quelli della foresta di West Point, tra New York e il Canada, dove ogni tanto mi rifugio. Il mio viaggio più emozionante è stato nella foresta pluviale di Papua Nuova Guinea. Giorni e giorni di cammino, senza scarpe, se cadi rimani secco, di notte dormi in tenda vicino al fuoco.
Mi sono sentito scaraventato nell’età della pietra. Ma le persone, pur se ci sono ancora casi di cannibalismo, erano così dolci, amichevoli. Mi consideravano un bambino. Mi mostravano i fiori e mi volevano portare sulle spalle quando ero stanco. Mi sentivo al sicuro, lì con loro.
Se dovesse fare una sola raccomandazione a chi ha la passione della fotografia, cosa gli direbbe?
Io credo che si debba amare la vita per fare questo lavoro. E che bisognerebbe avere sempre l’attitudine di uno studente, essere curiosi, aver voglia di sapere. Essere un eterno studente, questa è la mia filosofia di vita, è questo che rende la vita interessante. Quelli che dicono “bene, non siamo più studenti” sono persone morte. Fotografare è quindi imparare continuamente, avere lo spirito di un bambino pur essendo un adulto. Io cerco di fare questo, guardare il mondo come un bambino. Credo sia importante dire: “oh guarda, non è fantastico?”. Guardare il cielo e vedere la sua bellezza, talvolta lo dico a chi mi accompagna.
Tanta gente che conosco è andata in pensione e io mi chiedo: cosa faranno ora si siederanno o passeranno il resto dei loro giorni a giocare a tennis? Io non posso neanche immaginare di andare in pensione. Sono piuttosto vecchio, ma la fotografia mi fa sentire bene. A volte non sto bene, ho il raffreddore; ma poi faccio foto, buone foto, e il raffreddore passa improvvisamente. È incredibile, ma è così. Fotografare è il mio segreto per restare giovane.
www.magnumphotos.com
www.eyestorm.com