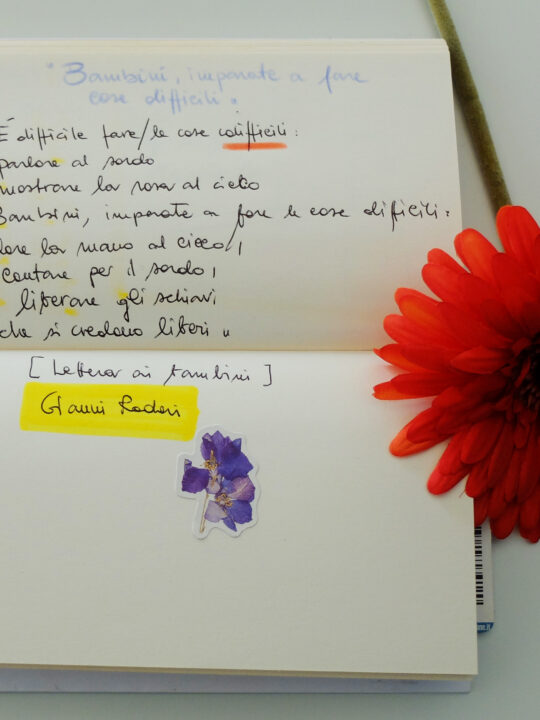Vittorini e la graffetta
Da "Conversazione in Sicilia", incipit. di Elio Vittorini
"Io ero, quell’inverno, in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi son messo a raccontare. Ma bisogna dica ch’erano astratti, non eroici, non vivi; furori, in qualche modo, per il genere umano perduto. Da molto tempo questo, ed ero col capo chino. Vedevo manifesti di giornali squillanti e chinavo il capo; vedevo amici, per un’ora, due ore, e stavo con loro senza dire una parola, chinavo il capo; e avevo una ragazza o moglie che mi aspettava ma neanche con lei dicevo una parola, anche con lei chinavo il capo. Pioveva intanto e passavano i giorni, i mesi, e io avevo le scarpe rotte, l’acqua che mi entrava nelle scarpe, e non vi era più altro che questo: pioggia, massacri sui manifesti dei giornali, e acqua nelle mie scarpe rotte, muti amici, la vita in me come un sordo sogno, e non speranza, quiete. Questo era il terribile: la quiete nella non speranza. Credere il genere umano perduto e non aver febbre di fare qualcosa in contrario, voglia di perdermi, ad esempio, con lui. Ero agitato da astratti furori, non nel sangue, ed ero quieto, non avevo voglia di nulla. Non mi importava che la mia ragazza mi aspettasse; raggiungerla o no, o sfogliare un dizionario era per me lo stesso; e uscire e vedere gli amici, gli altri, o restare in casa era per me lo stesso. Ero quieto; ero come se non avessi mai avuto un giorno di vita, né mai saputo che cosa significa esser felici, come se non avessi nulla da dire, da affermare, negare, nulla di mio da mettere in gioco, e nulla da ascoltare, da dare e nessuna disposizione a ricevere, e come se mai in tutti i miei anni di esistenza avessi mangiato pane, bevuto vino, o bevuto caffè, mai stato a letto con una ragazza, mai avuto dei figli, mai preso a pugni qualcuno, o non credessi tutto questo possibile, come se mai avessi avuto un’infanzia in Sicilia tra i fichidindia e lo zolfo, nelle montagne; ma mi agitavo entro di me per astratti furori, e pensavo il genere umano perduto, chinavo il capo, e pioveva, non dicevo una parola agli amici, e l’acqua mi entrava nelle scarpe."
Un brano attualissimo, di muta arrendevolezza verso ciò che sentiamo di non poter cambiare, perchè ci trascende e vanifica ogni velleità, ogni sussulto di rabbia. E dovremmo impugnare il bastone contro “la Malarazza”, magari l’abbiamo fatto, in qualche modo, ma si è spezzato al primo colpo su quei dorsi d’acciaio.L’ ingenua incredulità e poi il capo chino, come volendo, con uno stuzzicadenti, puntellare il grattacielo. E resta solo il pensiero furente e sanguigno che si traduce nella paralisi, catatonia eversiva pensante e improduttiva. La pioggia nelle scarpe, inesorabile, la carne del tempo e una quiete innaturale sul furore della mente in contorsione. Se dovessi pensare ad una sensazione fisica sarebbe il nodo in gola, quello del grido taciuto e dell’impossibilità comunicativa. Il silenzio prelude all’inazione, come il chiasso. E si vive di chiasso e silenzio, sincronicamente. Non sappiamo più leggere e leggerci ad alta voce, incatenati ad una balbuzie espressiva che ci snatura. Qualche piccolo Davide di fronte ad un esercito di Golìa. Questo profondo sentire porta a guardarsi indietro, nella storia personale e universale. Un ritorno rituale alle origini, del bene e del male. Dagli effetti alle cause, a ritroso, per far saltare fermi e sicure. Sciogliere qualche nodo della matassa per far scorrere il rocchetto. In certi momenti, imparare la filosofia del gambero. In altri momenti, invece, dimenticarla. Perchè c’è sempre, quando si pensa così, una piccola fiamma sotto l’oceano di cenere. Quel centimetro in cui si può ancora agire, fare qualcosa per sè e per il mondo. Che è come celebrare l’utilità della graffetta.
Delia Cardinale