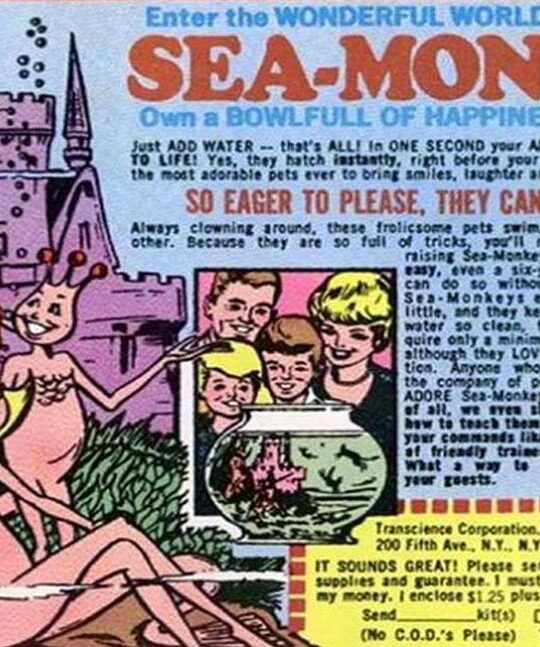Les Confessions
Le confessioni (o Confessioni) è il titolo di un’opera autobiografica di Jean-Jacques Rousseau. Oggi incluse negli Scritti autobiografici, uscirono a stampa solo postume (la prima parte nel 1782 e la seconda nel 1789). Esse raccontano i primi 53 anni di vita dell’autore in 12 libri. La redazione delle Confessioni iniziò nel 1764; Rousseau ne redasse i primi otto libri a Wootton, dopo la rottura dell’amicizia con David Hume e ne continuò la scrittura durante il suo rientro a Parigi. Nel 1771, Louise d’Épinay, appoggiata da Denis Diderot, chiese alla polizia di far interrompere le letture pubbliche che Rousseau ne stava facendo. La prima parte, con Preambolo e 6 capitoli, ricopre gli anni 1712-1740: sono gli anni di formazione, dalla nascita a Ginevra all’arrivo a Parigi, quando l’autore ha 28 anni. La seconda parte, dal capitolo 7 in poi, ricopre gli anni 1741-1765: la sua introduzione negli ambienti della capitale che si dedicano a musica e filosofia, con la pubblicazione delle opere e gli attacchi subiti dopo aver scritto Emilio o dell’educazione e la conseguente fuga in Svizzera. Il titolo sicuramente si rifà alle Confessioni di Agostino d’Ippona (meglio noto come sant’Agostino), scritte in latino nel IV secolo.
Un estratto dal Libro Secondo
Quanto m’era sembrato triste il momento in cui la paura mi ispirò il progetto di fuggire, tanto mi parve affascinante quello in cui lo attuai. Ragazzo ancora, abbandonare il mio paese, i miei parenti, ogni appoggio, ogni risorsa; piantare a mezzo un apprendistato senza conoscere il mio mestiere abbastanza per viverne; consegnarmi agli orrori della miseria senza intravedere alcun mezzo per uscirne; espormi, nell’ età della debolezza e dell’innocenza, a tutte le tentazioni del vizio e della disperazione; cercare lontano i mali, gli errori, le insidie, la schiavitù e la morte, sotto un giogo ben più inflessibile di quello che non avevo potuto sopportare: ecco a che cosa andavo incontro; questa la prospettiva che avrei dovuto affrontare. Com’era diversa quella che mi raffiguravo! L’indipendenza che credevo d’aver acquistato era il solo sentimento che mi dominava. Libero e padrone di me stesso, credevo di poter far tutto: bastava che mi lanciassi per librarmi e volare in aria. Entravo con sicurezza nel vasto spazio del mondo; i miei meriti lo avrebbero colmato: a ogni passo avrei trovato festini, tesori, avventure, amici pronti a servirmi, amanti premurose di piacermi: appena mostrandomi, avrei occupato di me l’universo, ma non proprio l’intiero universo, in una qualche misura lo dispensavo, non mi occorreva tanto. Una compagnia di amici affascinanti mi bastava senza darmi pensiero del resto. La mia moderazione mi circoscriveva in una sfera ristretta, ma deliziosamente scelta, dov’ero sicuro di regnare. La mia ambizione s’appagava d’un solo castello. Sorretto dal favore del signore e della dama, amante della damigella, amico del fratello e protettore dei vicini, ero soddisfatto, non mi occorreva di più. Nell’attesa di quel modesto avvenire, errai alcuni giorni intorno alla città, alloggiando presso contadini di mia conoscenza, che mi ricevettero tutti con bontà maggiore di quanta ne avrebbero mostrata persone di città. Mi accoglievano, mi ospitavano, mi nutrivano troppo bonariamente per averne merito. Non si poteva chiamarla un’elemosina: non ci mettevano abbastanza superbia. A forza di viaggiare e di percorrere il mondo, mi spinsi fino a Contignou, territorio della Savoia a due leghe da Ginevra. Il curato si chiamava signor Di Pontverre. Questo nome, famoso nella storia della Repubblica, mi colpì. Ero curioso di vedere com’erano i discendenti dei a «gentiluomini del cucchiaio». Andai a trovare il signor di Pontverre: mi accolse bene, mi parlò dell’eresia di Ginevra, dell’autorità della santa madre chiesa, e mi invitò a pranzo. Trovai poche obiezioni da opporre ad argomenti che si concludevano in quel modo, e giudicai che dei curati dai quali si mangiava così bene valevano almeno quanto i nostri ministri. Certo, ne sapevo più io del signor di Pontverre, per gentiluomo che fosse; ma ero troppo buon commensale per essere altrettanto buon teologo; e il suo vino di Frangy, che mi parve eccellente, argomentava così vittoriosamente per lui che avrei arrossito a chiudere la bocca di un ospite così generoso. Cedevo, dunque, o per lo meno non resistevo apertamente. Ad osservare gli espedienti cui ricorrevo, mi si sarebbe giudicato impostore. Sarebbe stato uno sbaglio: ero certamente onesto. L’adulazione, o meglio la condiscendenza, non sempre è un vizio, e soprattutto nei giovani è più sovente una virtù. La bontà con la quale un uomo ci tratta, ci lega a lui: non gli si cede per ingannarlo, ma per non rattristarlo, per non ripagarne il bene col male. Quale interesse induceva il signor di Pontverre ad accogliermi, a trattarmi così bene, a volermi convincere? Nessuno, fuorché il mio. Questo si diceva il mio giovane cuore. Ero pervaso di riconoscenza e di rispetto per il buon prete. Avvertivo la mia superiorità; e non volevo fargliela pesare in compenso della sua ospitalità. Non c’erano motivi ipocriti in questa condotta: non pensavo affatto a cambiar religione, e, lontanissimo dal familiarizzarmi tanto in fretta con un’idea del genere, la consideravo con un orrore che doveva allontanarmela molto a lungo. Volevo solo non indisporre coloro che a questo fine mi blandivano; volevo coltivare la loro benevolenza e lasciargli qualche speranza di successo, mostrandomi meno agguerrito di quanto fossi realmente. In questo la mia colpa somigliava alla civetteria delle donne oneste che, a volte, per raggiungere i loro scopi, sanno, senza nulla concedere e nulla permettere, far sperare più che non vogliano mantenere. Ragione, pietà, amore dell’ordine, senza dubbio imponevano che, lungi dall’assecondare la mia follia, fossi allontanato dalla rovina verso la quale correvo, restituendomi alla famiglia. È quanto avrebbe fatto, o tentato di fare, ogni uomo veramente virtuoso. Ma quantunque il signor di Pontverre fosse un buon uomo, non era certamente un uomo virtuoso; era anzi un devoto che non conosceva altra virtù se non adorare le immagini e recitare il rosario; una specie di missionario che per il bene della fede non immaginava di meglio che scrivere libelli contro i ministri di Ginevra. Anziché pensare a rispedirmi a casa, approfittò del mio desiderio d’allontanarmene per mettermi nell’impossibilità di ritornarvi quand’anche me ne fosse tornata la voglia. Si poteva scommettere che mi avrebbe mandato a morir di fame o a campare da mascalzone. Ma non era questo che egli vedeva: vedeva un’anima strappata all’eresia e restituita alla chiesa. Onest’uomo o mascalzone, che importanza aveva, purché andassi alla messa? Non bisogna credere, del resto, che questo modo di pensare sia peculiare ai cattolici; è di ogni religione dogmatica, in cui l’essenziale non stia nel fare quanto nel credere […]